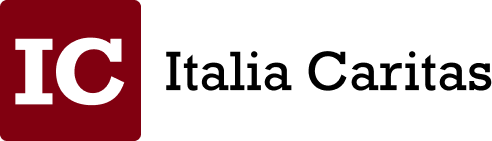2 | Cercare immagini di vita

Leggi l’articolo precedente dei quattro giovani in missione in Turchia >>
«Non capisco davvero perché le grandi televisioni mondiali siano andate laggiù a cercare immagini di morte. Non hanno capito nulla. In guerra, la vera immagine di Sarajevo era la vita. Il suo centellinare ogni residuo comfort, il suo attaccamento testardo ai riti di un’antica vita borghese». Così scrive Paolo Rumiz in “Maschere per un massacro”, il libro che racconta l’assedio ai danni della “Gerusalemme d’Europa” durante il periodo delle guerre dell’ex Jugoslavia.
Ad Iskenderun il contesto e la storia sono diversi: non si parla di guerra, ma di terremoto. Forse, però, la distruzione è ancora più grande. Eppure, il primo pensiero corre proprio a quelle parole: «La vera immagine era la vita».
Non siamo andati in Turchia, sei mesi dopo il terremoto, a cercare immagini di morte. Sarebbe stato semplice trovarle. Siamo andati invece a cercare la vita, e, al di là delle attese e delle immagini che ci possiamo formare nei momenti di preparazione a un viaggio, non è stato così complesso trovarla.
Anzi, forse è Lei, la vita, che ci è venuta incontro. La troviamo per strada, nella natura, nelle persone che prima si preoccupano di accoglierti e farti sentire a casa e poi ti raccontano la loro storia.

Da sinistra: Chiara Pellicci, Francesca Benenati, Santina Morciano, Andrea Bimbi
Chiunque penserebbe che chi da pochissimo ha subito un trauma così grande abbia altre preoccupazioni che dedicarsi all’accoglienza degli stranieri.
E invece l’ospitalità turca si manifesta subito con Sezar, il nostro primo incontro: in una sola cena ha voluto farci assaggiare tutte le specialità culinarie della città dove siamo atterrati, Adana, anche perché, come più volte ha sottolineato, ogni città ha il proprio prodotto tipico e quindi «il treno passa una volta sola». Lui e la moglie, Julide, lavorano per Caritas dal 2017 e sono stati colpiti dal terremoto: «Noi siamo fortunati perché stiamo bene» ripetono più volte, emozionati, durante l’intervista che abbiamo realizzato l’indomani. «Ma durante le scosse di terremoto, quando gli edifici sono crollati, molte persone invece hanno perso la vita oppure sono rimaste intrappolate vive sotto le macerie e chiedevano aiuto. Non c’era acqua, non c’era luce, sono stati giorni terribili. Per questo aiutando le persone troviamo sollievo al dolore del nostro trauma».
La vita emerge da chiunque si incontri, dal direttore della Caritas all’ultimo dei terremotati che ha perso tutto ma che, nonostante questo, ripete convinto e col sorriso di essere fortunato.
Samir, per esempio, tirocinante italo-giordano in Turchia, avrebbe potuto facilmente tornare a casa con un volo dell’ambasciata e invece ha scelto di restare: «Dopo le prime due ore di completo shock e spaesamento, ho realizzato di essere fortunato a trovarmi da solo nel Paese: la mia famiglia era sana e salva in Italia! Questa è stata una delle motivazioni per cui ho scelto di rimanere in Turchia e provare a dare il mio contributo» racconta lui che oggi è un operatore Caritas. Semi di vita Samir li scorge all’interno dei campi di sfollati, dove opera nella distribuzione degli aiuti materiali: li vede nell’impegno delle persone vittime del terremoto, che si danno da fare per rimettersi in gioco e ripartire. Come accade per esempio nel campo di Ovakent, un villaggio popolato da una comunità afghana che ha riportato ingenti danni e che Samir descrive così: «All’inizio era formato da una serie di accampamenti informali e poi pian piano le persone hanno iniziato ad organizzarsi, non concentrandosi più solo sulla propria abitazione, ma anche sulle difficoltà degli altri.

Sono così ripartite le prime attività: chi già prima era commerciante ha iniziato a vendere la propria merce in stand improvvisati, mentre davanti al campo si è formata una strada con diversi negozi e ristoranti».
Sono veramente tante le persone che non si sono lasciate abbattere dallo sconforto, ma che si sono rimboccate le maniche per supportare sé stesse e la propria comunità. Non si tratta solo di sopravvivenza, ma è la pienezza della vita che emerge: la solidarietà che abbiamo trovato all’interno delle comunità colpite è davvero commovente.
Nel campo formale di Ovakent (per campo formale si intende un agglomerato di alloggi temporanei per sfollati, composti da container o tende, allestito dal governo tramite l’ente AFAD, equivalente alla nostra protezione civile), Habibe ha (ri)generato la propria occupazione, il mestiere che la mamma le aveva insegnato da piccola: la sarta. Habibe ha 23 anni, un marito e tre figli: hanno deciso, con i pochi risparmi che avevano ancora a disposizione, di acquistare due macchine di seconda mano per far ripartire quella che era la loro attività. «Creando una cosa del genere la nostra intenzione è quella non solo di far sì che la gente possa avere un piccolo lavoro con cui guadagnarsi il pane a fine giornata, ma anche quella di offrire un’occupazione che permetta di distogliere il pensiero dal terremoto: io stessa sono la prima che beneficia di questo aspetto!».

La vita emerge anche da chi ha competenze e le mette a disposizione della comunità.
È il caso di Somsettin e Ahmed, originari di Ovakent e rispettivamente presidente e fidato collaboratore della fondazione da loro creata per sostenere la propria stessa comunità, sistemata alla bell’e meglio nel campo di Buhara, accampamento informale (auto-allestito da persone che non hanno i requisiti di accesso al circuito degli aiuti ufficiali) del villaggio di Ovakent. Il motivo per cui si sono organizzati in un ente sociale è che «molte volte si vuole fare del bene, ma dal punto di vista burocratico non è semplice. Allora abbiamo creato una fondazione ufficiale che ci ha così permesso di sviluppare altre attività».

Inizialmente hanno costruito e organizzato una cucina di comunità in grado di preparare più di 1000 pasti caldi al giorno, essendo la mancanza di cibo la prima esigenza da soddisfare a seguito del terremoto. Successivamente, si sono concentrati su come creare lavoro e garantire una vita più dignitosa per le persone del villaggio che hanno perso la casa. Tra i tanti progetti che intendono realizzare a breve, quello che hanno maggiormente a cuore prevede la costruzione di 75 container, così che almeno altrettante famiglie possano uscire dalla tenda, dove le condizioni di vita con temperature che in estate raggiungono i 45 gradi non sono facili. «È un lavoro che siamo in grado di fare noi, con le nostre competenze e capacità, senza dover acquistare i container da fuori e quindi risparmiando tanti soldi» raccontano con orgoglio. «È qualcosa che facciamo per noi e per il nostro popolo, non possiamo pretendere che siano solo gli altri a fare qualcosa. Siamo giovani, sani e lo possiamo fare.
Per noi l’obiettivo più importante è risorgere da soli: non pretendiamo nulla dal governo o da altri da fuori».
Anche John, il direttore della Caritas diocesana di Anatolia, ha visto sconvolta la situazione in cui era abituato a operare: «Posso dire che il terremoto ha avuto un aspetto negativo legato alle morti e le distruzioni, ma anche degli effetti positivi creando unità e fraternità nella nostra comunità. Tante persone infatti hanno iniziato fin dal primo istante a venire in chiesa mettendosi a disposizione. Voglio sottolineare che tanti di questi avevano perso la casa, ma si sono presentati da noi per mettersi a servizio degli altri. Il primo mese sicuramente è stato quello più duro, eppure avevamo 37 nuovi volontari fissi dalle 6.30 del mattino alle 23.00 ogni giorno per aiutarci a preparare i pacchi alimentari da distribuire alle famiglie. La solidarietà ovviamente è stata uno degli aspetti positivi nel buio di quel periodo che potete benissimo immaginare».

Non si è mai così poveri da non essere in grado di donare qualcosa agli altri. A dimostrazione di ciò, tra i diversi episodi di speranza accaduti in mezzo a una così vasta tragedia, John ricorda questo: «Alcuni rifugiati, che sono stati in passato nostri utenti, in questa situazione di difficoltà hanno realizzato fra loro una piccola colletta di prodotti e li hanno inviati qua per la distribuzione. Queste sono cose bellissime che fanno vedere che il cuore dell’uomo non è indifferente. Alla gente interessa, eccome, la situazione degli altri!».
Quando, nonostante lo sconforto e le difficoltà, l’attenzione principale diventa l’altro, lì sì che la Vita emerge.

Su “Italia Caritas” la missione di Chiara, Francesca, Santina e Andrea in Turchia continua: venerdì 4 agosto, a sei mesi dal terremoto (6 febbraio 2023), un nuovo articolo recconterà più nel dettaglio la situazione in Turchia e Siria.
Aggiornato il 04/08/23 alle ore 14:09