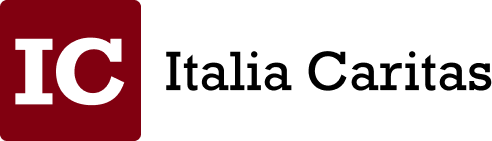Un dolore che unisce | 1

Il macabro spettacolo che si offre a chi si prepara ad atterrare allo spettrale aeroporto di Malakal, città dell’Alto Nilo in Sud Sudan al confine col Sudan, è quello di un apparente abbandono.
Quella che fino a 10 anni fa, è stata la seconda città del Sud Sudan con i suoi oltre 200.000 abitanti e fra le più fertili per la produttività agricola che il Nilo assicura, appare un polveroso campo di battaglia: ogni edificio distrutto, macerie arse in ogni isolato, accampamenti di fango, infrastrutture ridotte a relitti, pali della luce un tempo funzionanti inclinati ad arrugginire. Sul volto della città si legge l’eredità della guerra civile che ha martoriato il Sud Sudan dal 2013 al 2018 e devastato Malakal all’indomani dell’indipendenza nel luglio del 2011.
Durante la guerra il controllo della città è passato di mano più volte fra le milizie composte da mercenari, spesso non retribuiti, abituati ad auto-pagarsi con saccheggi e a praticare vessazioni d’ogni genere. I primi ad arrivare portavano via cibo, bestiame e il trasportabile, chi arrivava dopo si appropriava del legno di porte e finestre, e così via fino al materiale di cui le stesse capanne erano costruite. Le lamiere erano particolarmente ricercate, struttura portante d’ogni abitazione: ogni raro edificio superstite mostra una scarnificazione fino alla sua stessa ossatura. Il non trasportabile veniva bruciato, nessuna capanna o veicolo è rimasto integro, forse anche in preda ad una sorta di sulfurea euforia distruttiva.
Sul volto della città si legge l’eredità della guerra civile che ha martoriato il Sud Sudan dal 2013 al 2018 e devastato Malakal all’indomani dell’indipendenza nel luglio del 2011

Cosi come la Cattedrale, la casa delle Suore Comboniane non è stata risparmiata, occupata e disintegrata in più punti: «Siamo tornate qui solo a settembre scorso», ci dicono durante la cena, illuminata da una tenue lampadina solare. Né, del resto, la situazione si è mai stabilizzata del tutto nonostante la pace raggiunta da qualche anno: «Ora sta andando bene: già da due mesi qui è tranquillo, niente scontri», dice Suor Elena Balatti, comboniana e direttrice di Caritas diocesana di Malakal.
La città non ha un’economia, poco è stato ricostruito salvo edifici governativi a un piano, e quasi mancano sanità ed istruzione. Il tragitto – di notte in totale oscurità – è costellato da accampamenti che narrano la storia di una sovrapposizione d’emergenze, nessuna delle quali mai risolta, anzi rinnovata nei suoi effetti sulla popolazione da quella successiva.
L’accampamento più recente all’entrata della città, il più piccolo, ospita 2.000 persone in tende di plastica, vittime dell’ultima inondazione un anno fa. Ma il campo più grande è il POC – Protection of Civilians: gli abitanti di Malakal, ormai abbandonata la città, vivono in realtà qui a qualche chilometro da essa. «C’è stato un momento nel 2015», spiega Suor Elena «in cui nella città intera non c’era più nessuno, il totale deserto»: tutti e 200.000 erano fuggiti per scampare dalle vessazioni. Solo 40.000 di loro sono poi tornati nel campo, ormai la ‘nuova Malakal’ dalla quale pochi rischiano di allontanarsi. I Caschi Blu, mal visti dalla popolazione, ne sorvegliano l’entrata: questi, privi del mandato di operare, durante le fasi del conflitto non sono mai intervenuti per impedire saccheggi o violenze.

Questa era la situazione di Malakal su cui si è abbattuta la nuova catastrofica crisi umanitaria dal confinante Sudan, in guerra civile ormai dal 15 aprile 2023. Qui, i due militari ex-alleati nel colpo di stato dell’ottobre del 2021 sono oggi a capo di due fazioni contrapposte: l’esercito regolare sudanese (SAF) del Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, Abdel Fattah al-Burhan, contro le Forze di Supporto Rapido (RSF) del vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo. Alle rivalità personali si sommano divergenze di interessi e visioni politiche sul futuro del paese, lotta per le risorse e influenze esterne. I combattimenti iniziati a Khartoum, si sono poi estesi in tutto il paese, soprattutto in Darfur, Kordofan, Gezira. Nel Darfur, il conflitto ha assunto connotati etnico-tribali dei gruppi arabi nei confronti delle comunità Masalit e si sono riprodotte le dinamiche di violenza etnica, con uccisioni e stupri di massa, già viste in passato. Nessun posto è ormai sicuro e ovunque fin da subito gli effetti si sono fatti sentire direttamente, con atrocità, o indirettamente, con l’interruzione d’ogni efficace servizio per cibo, comunicazione, liquidità, sanità.
7.8 milioni di nuovi sfollati da aprile 2023, di cui oltre 6 milioni interni e 1.6 milioni nei paesi vicini
Ciò ha reso il Sudan sede della peggiore crisi da sfollati del mondo alla fine del 2023, con almeno 7.8 milioni di nuovi sfollati da aprile 2023, di cui oltre 6 milioni interni e 1.6 milioni nei paesi vicini. Di quelli interni, almeno due terzi sono in Sud, Est e Nord Darfur, River e White Nile, e Gezira; i 1,6 milioni esterni sono nei vicini Ciad, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Egitto, Etiopia. Le conseguenze più generali hanno provocato una situazione che colpisce almeno il 37% della popolazione, 18 milioni di persone vittime di crisi alimentare associata a condizioni di precarietà igienica: 10,000 i casi di colera e almeno 275 morti in 11 stati. Quanto alle stime parziali delle vittime degli scontri, erano a fine gennaio fra i 12.000 e i 15.000. Purtroppo le responsabilità esterne sono rilevanti avendo goduto i due generali dell’appoggio o quantomeno dell’indifferenza della comunità internazionale. Responsabilità aggravata dalla fornitura nel passato di sostegno economico e tecnico al Sudan anche da parte dell’Unione Europea e dell’Italia per il controllo dei flussi migratori, aiuti utilizzati anche per rafforzare e armare “le forze di sicurezza” che ora fanno la guerra.
Continua nel prossimo articolo
Aggiornato il 05/03/24 alle ore 08:36