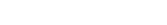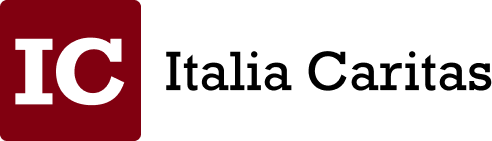Ban Nam Keem vent’anni dopo lo tsunami

Credits: Ansa
«Un’onda alta come una montagna», così Wimon Thongthae, gestore di un piccolo negozio di alimentari, ricorda lo tsunami che ha raso al suolo il villaggio di Baan Nam Keem nelle prime ore della mattina del 26 dicembre 2004, portandosi dietro il figlio minore.
Quello tsunami, generato da un potente terremoto subacqueo di magnitudo 9.1, è ricordato come uno degli eventi più catastrofici della storia moderna. In poche ore ha colpito le coste dell’India, Indonesia, Malesia, Maldive, Myanmar, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Tanzania e Tailandia provocando un totale di 230 mila vittime.
26 dicembre 2004

Prayoon Jongkrajiug, pescatore residente a Baan Nam Keem all’epoca della catastrofe, ricorda il mare eccezionalmente calmo di quella mattina, l’aria immobile, senza un filo di vento. Poi, verso le 10, le chiamate da Phuket rompono la quiete: amici e conoscenti avvertono dell’arrivo di un’onda gigantesca che ha appena travolto la costa poco più a sud. Nel frattempo, i pescatori di Baan Nam Keem vedono il mare ritirarsi ad una velocità insolita e danno l’allarme. Quarantacinque minuti dopo, un boato squarcia l’aria e un’onda alta dieci metri si abbatte con violenza sulla riva. Il mare, che da sempre aveva nutrito il villaggio, ora lo inghiottiva con furia distruttiva.
Quello tsunami, generato da un potente terremoto subacqueo di magnitudo 9.1, è ricordato come uno degli eventi più catastrofici della storia moderna. In poche ore ha colpito le coste dell’India, Indonesia, Malesia, Maldive, Myanmar, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Tanzania e Tailandia provocando un totale di 230 mila vittime.
Nel 1998, ricorda Jongkrajiug, oggi presidente del Disaster Network della provincia di Phang-Nga, c’era già stata un’allerta tsunami sulla costa delle Andamane: donne e bambini erano stati evacuati preventivamente ma l’onda non era mai arrivata. Fatta eccezione per questo episodio, né la comunità né le autorità locali conoscevano il fenomeno, tantomeno possedevano gli strumenti per fronteggiarlo. Infatti, l’allarme lanciato dai pescatori fu ignorato da molti. Alcuni restarono persino sulla spiaggia a osservare il mare gonfiarsi all’orizzonte, perdendo così la vita.
«Ci furono tre onde», racconta Jongkrajiug, con la precisione di chi ha ripetuto questa storia molte volte. La prima, alta poco più di un metro, destò confusione per la velocità con cui aveva raggiunto la costa dopo che il mare si era ritirato in maniera altrettanto insolita; la seconda, devastante, si era alzata fino a dieci metri mentre la terza aveva amplificato la forza distruttiva della precedente.
Pochi secondi dopo che l’onda si è abbattuta sulla costa, il villaggio è stato inghiottito dal caos, continua Jongkrajiug, occhi fissi a rievocare le immagini del momento. Descrive i volti dei suoi vicini di casa che, in preda al panico, correvano verso il mare senza sapere dove rifugiarsi o tentavano disperatamente di salvare quel poco che restava delle loro case. C’era chi, attonito, realizzava di aver perso tutto, come quell’uomo che, la mente annebbiata dal dolore, stringeva una bombola di gas e la trascinava verso l’acqua – come nella speranza che il gesto potesse riportargli indietro la moglie.
Prima che lo tsunami si abbattesse sulla costa tailandese, ne modificasse il paesaggio e lasciasse una cicatrice indelebile nell’anima della comunità, Baan Nam Keem ospitava circa 10.000 persone. Era una comunità ricca e fiorente. La memoria di Jongkrajiug conta 1.800 nuclei familiari presenti nel 2004, per un totale di 4.800 residenti. A questi, ci tiene a sottolineare, vanno sommati i 2.000 abitanti non registrati e i 3.000 lavoratori birmani, molti dei quali senza documenti in regola. I suoi modi gentili tradiscono la rabbia nel rievocare i numeri delle vittime: 687 secondo i dati ufficiali, ma oltre 1.200 se si considerano anche le denunce di scomparsa – mai riconosciute nel conteggio ufficiale – e le vite di chi, senza documenti, è rimasto invisibile agli occhi delle autorità.
La ricostruzione: sfide e insegnamenti


All’indomani della catastrofe, la risposta del governo si è sovrapposta a quella delle ONG, delle imprese del settore privato e della comunità stessa, generando confusione e duplicazione degli aiuti. Padre Suwat Luangsa-ard, al tempo assistente nella parrocchia di Hat Yai, nel sud della Tailandia, sottolinea più volte la mancanza di coordinazione tra gli aiuti: «ad alcuni sfollati sono state assegnate più case mentre altri non hanno ricevuto nulla». Infatti, gli aiuti governativi si sono concentrati sulla risposta immediata, a discapito di progetti per la ricostruzione e la sostenibilità a lungo termine. Obiettivi, questi, di cui si è fatta carico la società civile. In certi casi, l’assistenza era persino ridotta a piccole somme di denaro distribuite in maniera frammentaria, spesso fonte di rancori e litigi, come ricorda Jongkrajiug con un sorriso amaro.
«Le priorità post-tsunami si ridussero a due grandi problemi», continua lui: radunare gli abitanti di Ban Nam Keem che si erano spostati altrove in cerca di rifugio, e restituire un tetto a chi aveva perso tutto. Un’altra questione era quella dei servizi igienici: «non potevamo sistemare la gente se non c’erano bagni comuni» ripete. Solo dopo la realizzazione delle prime latrine e l’organizzazione dei rifugi, infatti, il numero degli sfollati nel villaggio si è stabilizzato intorno ai 1000.
A questo punto emergeva un ulteriore problema: come guidare una comunità a cui non è rimasto niente e che, malgrado ciò, è chiamata a guardare avanti? Con l’aiuto delle autorità locali, delle ONG e della rete Caritas gli abitanti del villaggio hanno elaborato un efficace sistema di autogestione. «Le tende degli sfollati sono state organizzate in unità», spiega Jongkrajiug, evidenziando con orgoglio il coinvolgimento diretto del fratello. «Cinque file formavano un blocco, ciascuno sotto la supervisione di un responsabile». L’idea era chiara: le vittime non erano pazienti in attesa di soccorso ma persone capaci di prendere decisioni e trovare soluzioni ai propri problemi. Così sono nati anche dei “gruppi di lavoro” – alcuni attivi tutt’ora – i cui membri venivano assegnati a delle mansioni utili per la comunità, oltreché per alleviare lo stress e il sentimento di impotenza.
Purtroppo, non tutto è andato secondo i piani. La corruzione ha trovato presto spazio tra i detriti. «Erano stati stanziati 200.000 baht per ogni proprietario di un allevamento ittico, eppure quei fondi finirono anche nelle mani di chi non era mai stato pescatore» racconta Thongthae, la voce intrisa di rabbia. Lo conferma anche Songwut Inthasawat, all’epoca rappresentante dell’autorità provinciale, che riconosce come un sistema normativo più solido avrebbe giovato non solo ai beneficiari ma anche che ai creditori. Per Jongkrajiug, invece, è stata la speculazione sulla terra a lasciare un senso di ingiustizia ancora vivo nonostante il tempo passato. «È stato terribile vedere le famiglie Moken – i cosiddetti ‘zingari del mare’ – private della loro terra, che abitavano da generazioni ma senza un certificato di proprietà a tutelarle».
Il ruolo di Caritas nella ricostruzione post-tsunami
Dopo lo tsunami, la rete Caritas, insieme alle Chiese locali, si è mobilitata per sostenere la ricostruzione delle comunità colpite, con particolare attenzione rivolta a chi rischiava di essere trascurato dagli aiuti governativi: pescatori, migranti birmani e le popolazioni Moken.

«Non è stato facile coordinare la rete di solidarietà nata dopo il disastro», spiega Padre Suwat, oggi direttore del Diocesan Social Centre (DISAC) di Surat Thani. A differenza di altre aree coinvolte, Khao Lak – una delle zone più colpite – non aveva una comunità ecclesiastica di riferimento che potesse offrire supporto. «In questo contesto, il sostegno di Caritas è stato fondamentale». Caritas, continua Padre Suwat, ha contribuito a identificare i bisogni più urgenti e ha finanziato una serie di interventi, partendo dal soccorso immediato per poi investire su percorsi di più lungo termine: educazione, opportunità di lavoro, salute mentale, prevenzione delle emergenze, microcredito e supporto alle politiche sociali locali. «È proprio in quest’ottica che è nato il DISAC di Surat Thani, a partire da un approccio di accompagnamento in stile Caritas che non si è limitato alla fase emergenziale, ma che ha puntato allo sviluppo sostenibile della comunità».
«In questo contesto, il sostegno di Caritas è stato fondamentale» partendo dal soccorso immediato per poi investire su percorsi di più lungo termine
Una volta terminata la ricostruzione post-tsunami, il DISAC ha continuato a rispondere alle nuove sfide che riguardano la comunità: il numero crescente di migranti birmani in cerca di migliori opportunità di lavoro, e la condizione precaria della popolazione Moken. In questo percorso si inserisce anche la presenza dei Caschi Bianchi, «un punto di continuità importante per la comunità locale» secondo Padre Suwat.
La comunità vent’anni dopo

Ma cos’è rimasto di quella tragedia vent’anni dopo? «La solidarietà, il ricordo e la consapevolezza che lavorare insieme è indispensabile alla sopravvivenza della comunità» afferma senza dubbi Inthasawat. È certo che il trauma subìto è servito da collante, avvicinando ricchi e meno ricchi, funzionari del governo e pescatori, tailandesi e non, tutti sgomenti di fronte alla forza del mare. Ed è stata questa stessa consapevolezza a svegliare le coscienze sul tema del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello del mare, sostiene Inthasawat. Un tema, quest’ultimo, che sta molto a cuore alle generazioni più giovani.
Cos’è rimasto di quella tragedia vent’anni dopo? «La solidarietà, il ricordo e la consapevolezza che lavorare insieme è indispensabile alla sopravvivenza della comunità»
Quanto ai cambiamenti principali, Jongkrajiug, sicuro, ne conta tre. Prima di tutto la popolazione di Ban Nam Keem è diminuita. Poi, il paesaggio è cambiato: le dune di sabbia che fungevano da riparo per le barche dei pescatori contro le raffiche di vento non ci sono più. Infine, la vita del villaggio è diversa, laddove era stato il mare a dare nutrimento agli abitanti di Ban Nam Keem, oggi sono perlopiù i turisti.
L’ottimismo per il futuro e la concretezza della vita presente di chi cerca di lasciarsi alle spalle il passato convivono con il dolore di chi ancora non ha superato il senso di ingiustizia per la perdita dei propri cari. Ed è in questo equilibrio tutto tailandese che riemerge l’anima di Ban Nam Keem, vent’anni dopo l’evento che ne ha irrimediabilmente plasmato l’esistenza.