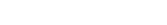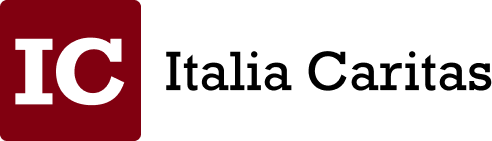Il Risorto: lo straniero che cammina con noi

Il Risorto: lo straniero che cammina accanto a noi .pdf
Umanità che «si ferma» e disumanità che «passa oltre» don Matteo Pasinato – FTTR .pdf
«Chi lotta con amore per la giustizia, per un lavoro per tutti, per l’equilibrio per l’ambiente; chi si impegna per utopie realistiche come la visione di una nuova umanità, curando quel vincolo di alleanza, di mutua fiducia, di stupore, di accoglienza reciproca, favorisce e stimola una cultura della speranza». Carlo Maria Martini
Ogni giorno partecipiamo a discussioni e ascoltiamo conversazioni, sia a livello personale che nel contesto politico e mediatico, riguardanti stranieri e migranti. Ogni giorno incontriamo volti diversi che chiedono di essere accolti nella loro irriducibile diversità. Tuttavia, la paura talvolta ci blocca, facendo sì che queste conversazioni e questi incontri non sempre si traducano in un atteggiamento ospitale e inclusivo.
L’episodio dei discepoli di Emmaus, che la liturgia ci propone nel tempo pasquale, ci presenta il Risorto nei panni di un viandante, descritto come «straniero» (Lc 24,18). Nella sua vita, Gesù assume il volto dell’altro.
Gesù è lo straniero che cammina con gli uomini, che resta nascosto fino a quando, invitato a tavola, viene riconosciuto nel gesto di condividere il pane. È nella condivisione, nello stare insieme, nel conversare, nel fare memoria di ciò che si è vissuto, che avviene il riconoscimento e lo straniero si rivela.
Nel celebrare la Pasqua, è indispensabile ricordare la nostra chiamata a riconoscere, in chi ci cammina accanto e in chi condivide le nostre stesse strade, il Risorto.
Lo straniero non è solo qualcuno da accogliere, un destinatario del nostro amore, ma anche una figura critica capace di metterci in discussione, permettendoci di «aprire i nostri occhi» e «farci ardere il cuore».
Per questo è indispensabile superare pregiudizi e paure per sperimentare un autentico dialogo, cioè quel luogo privilegiato in cui ciascuno rimane sé stesso e, al contempo, accetta il rischio di diventare altro. È nel dialogo che l’altro, diverso da me, diventa rivelazione di un dono, rivelazione di Dio. Così come la Parola ci narra attraverso l’esperienza di Abramo nell’accoglienza dei tre stranieri alle querce di Mamre.
Abramo, il primo credente nel Dio unico, rivela il suo Dio non tanto con le parole, quanto piuttosto mostrando la sua umanità nell’accogliere chi arriva presso di lui.
Dinnanzi ai tre stranieri, Abramo sa ascoltare: comprende che l’uomo è sia parola che silenzio, parola che nasce dal silenzio. Il padre dei credenti, che per primo ha ascoltato la voce di Dio, ora sa ascoltare anche questo silenzio eloquente. Chi è abituato ad accogliere la Parola dall’Altro è anche pronto a ricevere l’appello che proviene dall’altro uomo.
Ascoltare e accogliere Dio mi prepara ad ascoltare gli altri.
Ciò che Abramo compie e dice è solo una conseguenza del suo ascolto: si fa prossimo ai tre stranieri, corre loro incontro, si prostra a terra davanti a loro e li supplica di fargli il dono di essere suoi ospiti.
I gesti di Abramo esprimono la sua capacità di ospitalità: non chiede i nomi dei suoi ospiti né vuole sapere da dove vengano o cosa desiderino, ma rende loro omaggio. Egli si sottomette, inchinandosi fino a terra, e, dopo aver reso onore a questi sconosciuti, rivolge loro la parola: «Mio Signore (Adoni), se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo» (Gen 18,3).
In queste parole di Abramo vi è dunque l’essenza dell’ospitalità, che è un servizio, ed è autentica solo quando chi la esercita riesce a farsi servo dell’altro, a trattarlo come suo signore, come il Signore.
Abramo vuole ristorare i viandanti. Infine, ciò che è più importante, lui stesso serve i suoi ospiti. La sua volontà che gli ospiti siano felici, il suo desiderio che essi possano godere non solo del nutrimento necessario, non solo di un cibo ben curato, ma possano vivere un banchetto festoso.
Prima di parlare, di intessere un dialogo, bisogna sedersi, distendersi, mangiare; è una verità estremamente semplice, ma gli uomini dimenticano facilmente che prima dell’«ospitalità delle convinzioni», viene quella dei corpi. I tre stranieri sono così serviti: i tre a tavola, Abramo in piedi presso di loro, in uno shalom, in una calma serena che testimonia la qualità umana del pasto.
È la pace profonda che nasce dalla donazione, perché è donando che si riceve, ed è accogliendo il dono che si può donare nuovamente. Così i tre ospiti narrano la pace, nel silenzio abitato dalla premurosa sollecitudine di Abramo.
L’evento dell’ospitalità diviene evento di rivelazione:
«Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio» (Gen 18,10).
Il dono di Dio risponde al dono fatto da Abramo ai tre stranieri:
Abramo padre della discendenza di Israele, Sara feconda nel sorriso, il padre e la madre di tutti i credenti.
Si potrebbe dire che, da Abramo in poi, Dio, attraverso i suoi inviati e in modo particolare in Gesù Cristo, si fa pellegrino, ospite e straniero sulla terra, chiedendo accoglienza agli uomini.
Aggiornato il 08/04/25 alle ore 12:35