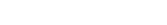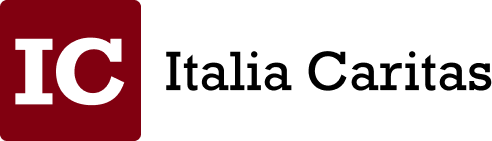Tutto è connesso

Dieci anni della Laudato Si’ sono un tempo importante. Eppure forse un tempo ancora non del tutto sufficiente per tracciare un bilancio completo dell’impatto di questo documento, sia rispetto il mondo ecclesiale e che per l’intera comunità civile globale[1]. Ci interroghiamo sul posto che questo documento, in un dialogo tra mondo civile e dottrina sociale sui temi della “casa comune” che non nasce con esso, ma che con esso trova un punto di svolta probabilmente storico. Così come controversa fu l’accoglienza di un altro documento che riconosciamo come storico, quella Pacem in Terris che Giovanni XXIII in una fase drammatica della guerra fretta, ugualmente lo è stata anche quella della Laudato Si’, solo in parte compresa nel mondo ecclesiale ma dimostratasi strumento di dialogo potente con l’intera comunità civile. La Laudato si’ ha sfidato e sfida la comunità dei credenti non sempre pronta a coglierne l’appello; ma per credenti e non credenti indica una strada nella grande sfida del senso del nostro tempo, fino al punto da spingere un grande pensatore come Edgar Morin a definirla come “laicamente provvidenziale” in un’epoca desertica di pensiero[2]; o come lo scrittore indiano Amitav Ghosh, che mette a confronto il testo della Laudato Si’ con quello dell’Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico, trovando nel primo la semplicità, la forza della chiarezza (financo disturbante), la tensione verso la giustizia che riconosce la povertà e l’esclusione come il frutto di scelte ben precise; tutte attenzioni che mancano invece al secondo, testo fondamentale perché esito di una convergenza difficilissima eppure essenziale, ma diluita e stemperata, frutto del cesello di centinaia di negoziatori e diplomatici.[3]
L’impatto più importante della Laudato Si’ però è forse quello che deve ancora arrivare.
Siamo stati tutti colpiti dall’affermazione “Tutto è connesso”, al n. 16 dell’enciclica. È un’intuizione potente, affascinante, ma anche destabilizzante. La troviamo citata di frequente, ci attrae, ma al tempo stesso ci mette in difficoltà. “Tutto è connesso”, sì… ma in fondo possiamo occuparci solo di alcune cose: quelle che sappiamo fare, che ci danno soddisfazione, che riusciamo a gestire. In fondo non è sorprendente che questa frase ci spinga, almeno in prima battuta, a concentrarci su ciò che ci è familiare, e che ci appare più rassicurante. Eppure, quel “tutto è connesso” ci suggerisce un cammino diverso da quello a cui siamo abituati, alludendo a un mondo altro, che ancora non conosciamo proprio perché non esiste ancora – e che possiamo appena cominciare a immaginare. In un tempo di transizioni rapidissime – un vero e proprio “cambiamento di epoca”, come papa Francesco ha più volte ricordato – facciamo fatica a leggere questo cambiamento, a orientarci. Ne deriva spesso una forma di evitamento cognitivo: la sfida ci sembra troppo grande, e allora ci allontaniamo, torniamo su terreni a noi più familiari, cercando giustificazioni. Possiamo ancora forse chiudere gli occhi di fronte a questa sfida, ma non possiamo più sottrarci ad essa: è già il contesto in cui viviamo. È il mondo in cui cresceranno le nostre figlie e i nostri figli, le generazioni future.
“Tutto è connesso” è anche un invito a una lettura critica delle nostre pratiche e strutture consolidate: quelle che abbiamo sempre portato avanti e che magari hanno funzionato, ma rispondevano forse a domande che oggi non sono più le stesse. Quando affrontiamo problemi nuovi e complessi, la prima reazione è spesso quella di proporre “buone pratiche”: soluzioni valide altrove e che ci rassicurano. Le replichiamo perché ci proteggono dal rischio del fallimento, ci evitano l’accusa di avventurismo. Se le cose andranno male, potremo sempre dire che ci siamo ispirati a un modello di successo. È la riflessione che faceva Bill Easterly, descrivendo la figura del pioniere che esplora percorsi di sviluppo, e che solo accettando di rischiare, avventurandosi in terreni inesplorati, apre la possibilità di trovare una terra nuova, con frutti che nessuno immaginava. “Tutto è connesso” significa accettare la sfida della complessità, dell’esplorazione, anche del fallimento.
È in questa chiave che deve essere letta l’idea per cui il grido della terra e quello dei poveri sono strettamente legati (LS 49), e che non può esistere una vera famiglia umana senza un’alleanza con il creato, la nostra casa comune; non ha senso un’attenzione verso le persone che sperimentano condizioni di fragilità senza una cura ugualmente attenta alla terra dove insieme abitiamo: “non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale.” (LS 139). Una sola crisi socio-ambientale è un vero e proprio programma di lavoro… ed esplorare queste connessioni influenza anche il modo in cui costruiamo organizzazioni e istituzioni. Spesso lavoriamo per compartimenti separati, che non dialogano tra loro. Ci diciamo: “Io mi occupo di questo, è quello che so fare, che ho sempre fatto!”. Certo, quel tema resta importante, ma oggi deve essere collegato ad altri in modi spesso ancora da immaginare.
Quante organizzazioni hanno un dipartimento per le questioni internazionali e uno per quelle nazionali, come se fossero mondi separati? Un ufficio che si occupa di conversione ecologica o di ambiente, e un altro che segue il tema delle politiche sociali… La riflessione sullo sviluppo sostenibile dovrebbe aiutarci a tenere insieme i pezzi. Invece, esploriamo la prospettiva della sostenibilità accontentandoci di seguire quanto è collegato ad un singolo SDG, rassicurati dal fatto che ci siamo sempre occupati – ad esempio – di acqua, di scuola, di divario di genere… e potremmo continuare così, forti del fatto che un obiettivo dell’Agenda 2030 ci legittima a mantenere la nostra attenzione focalizzata sul campo ristretto in cui ci sentiamo a nostro agio. “Tutto è connesso” ci invita a superare questa frammentazione e a parlare di sviluppo sostenibile come di una questione al tempo stesso globale e locale, sociale e ambientale.
Anche l’attenzione a chi vive una condizione di povertà e fragilità è toccata da questa consapevolezza. Nella cura e nel servizio verso le fragilità, non in senso puramente assistenzialistico ma come mandato alla condivisione di una responsabilità con tutto il corpo ecclesiale e civile – dobbiamo vedere la realtà con occhi nuovi: l’attenzione verso i poveri nelle nostre città non può essere separata da quella per le grandi transizioni che stiamo vivendo – energetica, ecologica, demografica, sociale, economica, politica. Come possiamo occuparci di guerre senza pensare alle condizioni necessarie per costruire la pace, e alla necessità di una governance globale democratica e multilaterale, in un tempo in cui prevale la legge del più forte? Come separare l’attenzione verso chi vive fragilità, dalle cause delle disuguaglianze crescenti, in un sistema che genera ricchezza riservata a pochi? Come distinguere la povertà nei nostri territori dalle dinamiche globali che ostacolano il cambiamento e che intrappolano nella stessa morsa anche i poveri del Sud globale?
Sono domande che ci tuffano in acque agitate, mettendo in discussione abitudini e organizzazioni abituate a percorrere strade già note. Tutto è veramente connesso, ma far penetrare questa consapevolezza nel nostro pensiero e nelle nostre azioni è forse il compito più difficile.
Come affrontare questa sfida? Da dove partire immaginare un futuro che non vediamo? Talvolta affrontiamo la complessità semplificandola, riducendola in “sottoproblemi gestibili”, con il rischio di ricadere in una nuova forma di riduzionismo, spezzettando la nostra visione in parti forse più gestibili trattabili, ma ancora una volta limitate. Oppure dobbiamo riformulare la questione, smontarla e rimontarla in un altro ordine, fornendo con un lampo di intuizione una diversa visione della stessa realtà e del modo in cui potrebbe cambiare. Usando una parola in inglese, potremmo dire reframing che può essere tradotta con “riformulazione” o “ricontestualizzazione” o “cambio di prospettiva”, o forse con tutte queste cose insieme. Abbiamo bisogno di guardare la realtà con occhi nuovi, e di essere aperti a quanto di essa potrebbe destabilizzarci. Nell’anno del Giubileo ci viene offerto uno strumento potente per compiere questa operazione, attraverso la speranza: non un ottimismo privo di basi e neanche il vago sentimento di bene che prende il posto dell’azione; quanto una forma di scommessa consapevole sull’inaspettato (un tema caro a Edgar Morin), che ci permette di intuire lo spazio per una riprogettazione creativa della realtà. Non è forse questo il “trasformare i segni dei tempi in segni di speranza” a cui papa Francesco ci invita provocatoriamente con questo Giubileo? (SnC, 9). Si tratta di una speranza “laica”, oggetto di riflessione per credenti e non credenti che vedono in essa uno spazio di cambiamento, e una delle possibilità su cui addestrarci: le cose cambieranno – profondamente, ed il modo in cui cambieranno dipende almeno in parte da noi, e dal modo in cui noi avremo immaginato una realtà diversa.
“La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi.” (LS 61) “Tutto è connesso” ci mette alla prova, in un modo che forse non ci aspettavamo. Abbiamo bisogno anche della speranza per vedere la realtà con occhi nuovi, per metterci creativamente a confronto con la complessità del mondo che viviamo, e delle trasformazioni che stiamo sperimentando.
[1] Vedi anche le riflessioni nel dossier curato da Mauro Bossi SJ “Laudato si’: il cammino di conversione continua” nel numero di maggio 2025 di Aggiornamenti Sociali.
[2] https://www.avvenire.it/agora/pagine/morin-enciclica-per-una-nuova-civilta
[3] Ghosh, Amitav. 2023. La grande cecità: il cambiamento climatico e l’impensabile. Vicenza: BEAT. Pp 181-
Aggiornato il 23/05/25 alle ore 07:47