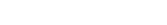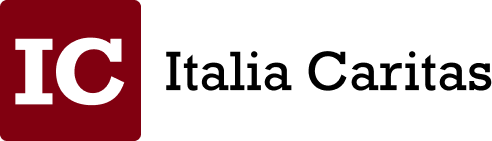La pace (im)possibile

Una domanda per questo nostro tempo: è ancora possibile pensare e sperare che arriverà il giorno in cui la guerra non sarà più utilizzata per regolare le relazioni e i conflitti tra gli stati?
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump lo scorso settembre emette un ordine esecutivo con il quale ripristina l’antica denominazione del Pentagono: “Dipartimento della Guerra” che era stata archiviata subito dopo la Seconda guerra mondiale a favore della definizione “Dipartimento della Difesa”. C’è un passaggio agghiacciante in quel documento: “il cambio di nome rafforzerà il focus di questo dipartimento sul nostro interesse nazionale e segnalerà agli avversari che l’America è pronta a ingaggiare guerra per garantire i propri interessi”.
La guerra come linguaggio del potere
Le atrocità commesse dall’alleanza nazifascista, le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, avevano espresso in modo evidente il potenziale distruttivo di cui è capace l’essere umano. Il desiderio di pace dopo tanti lutti, aveva stimolato l’impegno di tanti per provare a dare vita a un’epoca di pace in cui le controversie internazionali sarebbero state affrontate con la diplomazia grazie anche alle Nazioni Unite. Aspirazione costantemente frustrata dalle numerose guerre che insanguinano diverse aree del pianeta. In modo ancora più eclatante quel che è e sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Ucraina – solo per fare due esempi – certificano la pesante crisi e la sostanziale impotenza delle Nazioni Unite. Parlano le armi, la diplomazia fatica e la politica ancora di più. C’è un rifiorire della retorica sulla guerra come il vero strumento che possa garantire sicurezza. Sul breve periodo, purtroppo, continueranno a parlare le armi; il guaio aggiuntivo è che è di pochi la capacità di pensare politicamente, una locuzione cara in particolare a Giuseppe Lazzati, che significa assumere un atteggiamento responsabile verso la società, orientato al bene comune, coltivare uno sguardo critico e costruttivo sulla realtà sociale, economica e culturale che non può prescindere dallo studio e dalla ricerca. Ogni cittadino, credente o no, ha il dovere di “pensare politicamente” per contribuire con libertà e coscienza alla costruzione di una democrazia matura e partecipata.
In queste cinque righe una piccola sintesi di alcune delle precondizioni per stare dentro le crisi di questo nostro tempo con il necessario realismo e la speranza che la politica recuperi il ruolo che le spetta nel governo di processi che hanno sempre più una connotazione planetaria.
La pace come obiettivo e condizione
Come armonizzare il funzionamento di sistemi politico-sociali a volte nettamente diversi? Su quali valori rinnovare culture politiche che permettano di sviluppare una visione di società, una strategia che dia concretezza all’aspirazione di una società più giusta e più fraterna. Forse può ancora oggi venirci in aiuto uno dei documenti più significativi del post Concilio Vaticano II: l’enciclica “Populorum Progressio” di papa Paolo VI, in cui tra le tante intuizioni spicca la connessione che il Papa stabilisce tra sviluppo e pace del mondo, espressa in un principio che entrerà nella storia: «Lo sviluppo è il nuovo nome della pace». Non è possibile pensare allo sviluppo di un popolo se a questo gli si offre solo armi per la guerra. La pace come obiettivo e come condizione perché ogni uomo e ogni popolo si veda riconosciuto il diritto a vivere in pace. Oggi la gran parte delle culture politiche dominanti va in direzione contraria: la delicata questione dell’uso della forza, è lasciata in capo ai diversi stati. Un evidente salto all’indietro. Ci si riarma in modo massiccio, fiorisce il commercio delle armi. La nonviolenza, ridicolizzata e considerata roba da illusi. Settant’anni di pace relativa (perché non dobbiamo dimenticare la guerra nella ex Jugoslavia) non sono stati sufficienti all’Europa per costituirsi come una realtà politica forte e coesa; esercitare, in nome dell’essere stato teatro (tragico) di due Guerre mondiali, e dell’enorme patrimonio culturale e spirituale, il ruolo di punto di riferimento politico/culturale. Nessuno s’illude che sarebbe bastato, ma le incertezze, la lentezza nella realizzazione del progetto europeo ha privato il mondo di un interlocutore autorevole e pacificante. Ci sono allora altre domande a cui rispondere: che tipo di convivenza vogliamo costruire? Da subito, senza perdere tempo. È possibile stare dentro le contraddizioni e le tragedie del mondo ispirandosi a quella che possiamo definire un’antropologia evangelica? Quali scelte educative con le giovani e per le giovani generazioni che non siano un libro dei sogni e delle illusioni, ma incidano politicamente nella costruzione di una società planetaria giusta e fraterna?
La proposta di un “Ministero della Pace”
A gennaio del 1987, sulla rivista Italia Caritas, l’allora direttore di Caritas Italiana, Giuseppe Pasini ispirandosi al messaggio del Santo Padre per la 20ᵃ giornata mondiale della pace che aveva come tema: “sviluppo e solidarietà: chiavi della pace” con un evidente richiamo all’enciclica “Populorum progressio” emanata nel 1967da Paolo VI, lanciava la proposta di cambiare la denominazione del Ministero della Difesa in Ministero della Pace. Essa sottintendeva un cambio di paradigma che includesse studi, ricerche e sperimentazioni di difesa popolare nonviolenta, il concetto di difesa della patria non più limitato alla difesa dei confini territoriali, ma ampliato alla lotta contro le ingiustizie e contro la povertà, nella prospettiva di una progressiva trasformazione degli eserciti nazionali in un corpo di polizia internazionale alle dipendenze delle rinnovate Nazioni Unite. La costruzione della pace come processo partecipativo diffuso, senza nessuna delega esclusiva alla struttura militare, fondata sul rispetto del Diritto internazionale, che affronta con pensieri nuovi la gravissima crisi in cui si dibattono la gran parte degli organismi sovranazionali, Nazioni Unite comprese. Sono trascorsi quasi 40 anni da allora, per i costruttori di pace pensare politicamente è, ancora una volta, un’urgenza e una necessità.
PER APPROFONDIRE
Editoriale di don Giuseppe Pasini – Italia Caritas (Anno XX – n. 1 – Gennaio 1987) >>>