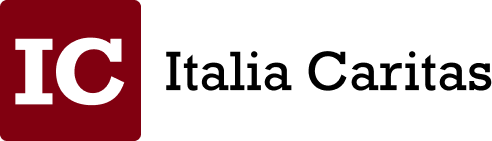Treviso: Valentina e la mostra “Poveri, ma…”

A volte un semplice “ma” può aprire a pensieri mai pensati prima. Intorno alla più piccola congiunzione avversativa quelli della Caritas di Treviso hanno costruito una Giornata dei Poveri e una mostra che ne è stata il fulcro: “Poveri, ma…”. Perché quel “ma” interrompe gli automatismi, indebolisce gli stereotipi, invita a rivedere ciò che pensiamo di sapere. E spinge a chiedersi cosa viene dopo: fragilità, certo, ma anche risorse; bisogno, sicuramente, ma soprattutto dignità. Valentina Pettenò, 41 anni, operatrice del Centro di Ascolto diocesano e referente del progetto Emmaus, di questo “ma” ha fatto un invito a guardare la povertà con occhi nuovi. Per gli altri e per sé stessa.
Il progetto Emmaus (pannelli mostra) | Pieghevole di presentazione della Casa della Carità
Lo scorso 16 novembre, Giornata mondiale dei Poveri, avete raccontato il progetto Emmaus, realizzato grazie ai fondi 8xmille di Caritas Italiana, attraverso una tavola rotonda, uno spettacolo teatrale e la mostra “Poveri, ma..”. Tutto questo presso il Duomo, in pieno centro storico. Luogo scelto perché “volevamo essere visti”. Treviso non vi conosce come dovrebbe?
«Treviso ci conosce, e non solo la città, ma l’intera diocesi. Tutti sanno dove siamo. Però sentivamo forte l’esigenza di essere ancora più visibili, di poter dialogare una volta di più, permettere alle persone della Casa della Carità – all’interno della quale prende forma il progetto Emmaus e che accoglie fratelli senza fissa dimora o in situazione di grave marginalità – di raccontarsi. Quest’anno abbiamo chiesto agli ospiti di partecipare pienamente come protagonisti, come portatori di creatività, risorse, potenzialità. E incrociato la loro esigenza di farsi conoscere meglio, anche attraverso i lavori della mostra».
La mostra propone i lavori dei vari laboratori con i volti frutto di un laboratorio particolarmente originale, quello di caricature, condotto da un ospite della Casa, fumettista. Il titolo è “Poveri, ma…”. Ma… cosa?
«Abbiamo scelto tutti insieme questo titolo. Ci abbiamo dedicato del tempo. All’inizio noi operatori cercavamo di capire se fosse possibile togliere proprio la parola “poveri” dal titolo. Ma gli ospiti della Casa della Carità hanno voluto lasciarla. “Noi siamo ‘anche’ poveri – ci hanno detto –, quindi vogliamo che ci sia scritto, però proponiamo di aggiungere dei puntini perché non siamo solo quello, ma anche… giovani, anziani, interessanti, banali, siamo portatori di tante cose”. Il loro bagaglio è ricco di capacità. E desideri».


Un “ma” occasione per ricordare che nessuno può esaurirsi in un aggettivo.
«Esattamente. E torno alla scelta del luogo così centrale: c’è sempre l’esigenza di abbattere lo stereotipo, il pregiudizio. La città domenica scorsa ha assistito a delle iniziative in cui ci ha visti tutti coinvolti in maniera attiva: operatori, volontari e ospiti. E spero siamo riusciti nell’intento di far interrogare su quella parola».
E far sostituire quei puntini.
«È proprio quello che chiediamo alla fine della visita alla mostra. Terminato il giro dei pannelli, i visitatori hanno trovato delle fettucce colorate in cui si invitava a continuare a scrivere quel titolo. Ognuno era chiamato a sostituire i puntini».
Tu, Valentina, cosa hai scritto?
«Io ho scritto: “Poveri, ma liberi di essere”».
Alcune scritte che ricordi?
«Quella di un signore: “Poveri, ma ricchi di speranze”, e di una ragazza “Poveri, ma ricchi di sogni”. Un ospite della Casa della Carità, che ha anche recitato nello spettacolo teatrale della sera, “C’era una volta un pezzo di legno”, ha scritto: “Poveri, ma stanno bene”».


Cosa ci dicono quelle opere in mostra?
«Che in questo momento sono senza casa, senza soldi per pagare le bollette, senza acqua corrente, non hanno una rete, né delle famiglie alle spalle o, se ce l’hanno, queste non possono dare loro una mano. Però hanno speranza. Sono persone, come tutti, con un passato, un presente e un futuro. E questo dovrebbe spingerci a non limitare lo sguardo, a guardare in maniera diversa, nuova gli altri. Tutti gli altri».
Quali riscontri dai visitatori della mostra?
«Ho visto persone molto meravigliate, felici di essere lì. C’erano occhi che brillavano. Ci hanno fatto un sacco di domande, hanno voluto approfondire la scelta del titolo. E ho avvertito tanta gratitudine per avere allestito questa mostra. Sono capitati diversi turisti, anche inglesi, che hanno trovato il titolo molto interessante. Tutti hanno mostrato curiosità nei confronti dell’iniziativa e di chi l’ha organizzata. Ovvero, lo ribadisco: ospiti, volontari e operatori».
Insomma, la sensibilità c’è. Va un po’ stimolata.
«Assolutamente. Torniamo ancora al discorso del volerci far vedere».

Emmaus, nella Casa della Carità, non è solo servizi, ma soprattutto partecipazione, creatività e relazione. Anche attraverso le tante attività come i laboratori. Con Emmaus si passa dal progetto al processo. In cosa consiste questa trasformazione?
«Nel cambio di punto di vista. Il nostro sguardo è cambiato e ha trasformato il progetto Emmaus in un processo che ci ha fatto osare, spingerci oltre i nostri limiti. Tramite azioni concrete, come gite, laboratori, feste, ma anche momenti molto semplici, informali, nati spontaneamente, ad esempio fermarsi a guardare una partita di calcio insieme dopo la cena o fare un gioco di società. Dunque non iniziative preconfezionate, con un orario stabilito. Quello che abbiamo capito è che il processo deve essere generato da noi per primi, con il nostro sguardo sulle cose, sulle persone che abbiamo accanto, su noi stessi anche. Il progetto ha dei confini prestabiliti: si parte con un analisi del contesto, un’ideazione, si realizza, si arriva alla fine e ci sono le verifiche. Il processo è qualcosa che non sappiamo dove ci possa portare. E che non ha grandi vincoli, per cui ci consente di pensare insieme a delle persone che hanno tempi diversi. Il processo coinvolge tutti gli attori in causa e questa è una particolarità potente. Il progetto quasi viene calato dall’alto e a un certo punto si rischia che alcuni lo subiscano».
Camminare insieme significa lasciarsi coinvolgere e cambiare. C’è un momento preciso in cui hai preso coscienza che in te era avvenuto un cambiamento?
«Io ho fatto tantissimi lavori prima di arrivare qui. Oggi sono al quinto anno in Caritas Treviso. La prima volta che ho messo piede in una mensa ero una volontaria e avevo 17 anni – 24 anni fa. Si trattava della mensa di Mestre, città da dove provengo. Quando sono arrivata in Casa della Carità, a Treviso, mi sono subito sentita… a casa. Nell’arco di questi anni c’è stata in me la voglia di realizzare i miei desideri, i miei sogni. Che non è solo fare l’educatore o il pedagogista – sbocco logico per gli studi universitari che ho fatto –, ma proprio mettermi a servizio, ascoltare, dare il tempo e il modo alle persone di parlare. Aver messo in pratica questo ha mosso molte cose dentro di me, mi ha fatto raggiungere una dimensione diversa, cercare di intuire quelle che potevano essere le capacità, i desideri delle persone che ho ascoltato».
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale dei Poveri 2025: “Dio ha assunto la loro povertà per renderci ricchi attraverso le loro voci, le loro storie, i loro volti”. Cosa si può fare perché questi volti continuino a essere guardati e non dimenticati?
«Anzitutto dar loro voce, e se non ce la fanno, dargliela noi, che significa anche fare advocacy, difendere i diritti; insomma, essere loro accanto, accompagnarli, ascoltarli. E godersele un po’ queste persone».


Archivio rubrica “Voci dai territori”
Aggiornato il 23/12/25 alle ore 21:11