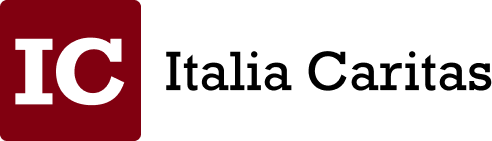Tony, volontario Caritas in un Libano al collasso

Fumano ancora le rovine del porto di Beirut. Una densa coltre grigia si alza metodica, silenziosa dai giganteschi silos di cemento armato semidistrutti, scarnificati dalla violentissima esplosione che il 4 agosto 2020 ha cambiato per sempre il volto alla città libanese. Duecentoventi le vittime, delle quali una ventina polverizzate dall’onda d’urto della deflagrazione di 2750 tonnellate di nitrato d’ammonio, stipate dal 2014 nel porto della capitale. E sono i volti di queste venti vittime, issati a mo’ di manifesto sui lampioni che scandiscono la luce lungo la litoranea Mar Mikhael, a creare quel memoriale che il governo libanese si è sempre rifiutato di costruire. Un governo contro cui il popolo disperato punta il dito, perché ritenuto il principale responsabile della tragedia.

I fatti successivi all’esplosione sembrano infatti confermare i sospetti: dai continui tentativi di insabbiamento delle inchieste, alla rimozione del giudice inquirente Fadi Sawwan che stava indagando su nomi di assoluto rilievo politico, fino ai tentativi avanzati dagli ex ministri dell’interno e dei lavori pubblici di estromettere dalle indagini anche il sostituto di Sawwan, il giudice Tarek Bitar. “I libanesi sono arrabbiati. Vogliono, verità, vogliono giustizia. Vogliono che il governo trovi e dia una pena esemplare ai responsabili di una tragedia che non può rimanere impunita”. Così racconta Tony Addad, 23 anni, volontario di Caritas Lebanon Youth, il dipartimento giovani della Caritas libanese. Tony è quello che si direbbe un “ragazzone”.
I libanesi sono arrabbiati. Vogliono, verità, vogliono giustizia
Alto un metro e novanta, corporatura robusta. Parla perfettamente molte lingue passando con nonchalance dall’inglese al francese, quest’ultimo da intendersi come eredità nostalgica del mandato di Parigi sulla Terra dei Cedri. “Sto frequentando con alcuni amici anche un corso on-line di italiano… ma mi prendono in giro perché l’insegnante dice che sono pigro” racconta ridendo.
Il lungo parapetto di cemento che separa la strada dal porto è decorato da una serie di murales realizzati dagli artisti della città: una giustizia bendata che regge una bilancia, il popolo in marcia sovrastato da un’imponente bandiera del Libano, i volti delle vittime diventati ormai iconici. E poi una scritta in elegante calligrafia araba: dualati faalat hada, vale a dire “è stato il mio governo a fare questo”, una frase che ha quasi il valore di didascalia davanti allo scempio del panorama portuale. “Ogni notte veniva qualcuno a cancellare questa scritta. Ma ogni mattina un libanese prendeva in mano pennello e la riscriveva. Metteva nero su bianco la sua accusa nei confronti dei politici, finché poi non è stata più cancellata”.

Tony è stato fra i primi a prestare soccorso al momento dell’esplosione. “Non potrò mai dimenticare quel giorno. Era un martedì. Erano le 18:07 quando Beirut ha tremato di paura e dolore. Fortunatamente è successo tutto nel tardo pomeriggio per cui migliaia di persone erano già uscite dagli uffici per tornare alle proprie case… molte vittime sono infatti state causate dagli effetti secondari dell’esplosione, soprattutto dai vetri delle finestre che hanno letteralmente dilaniato corpi a metà. Alle 19:20 ero già operativo con i volontari di Caritas Lebanon Youth, in uno dei due presidi-tende allestiti, a prestare soccorso alla popolazione colpita”.
Migliaia i giovani arrivati da tutto il Paese che hanno curato feriti, pulito le strade dai detriti, risistemato case e negozi sotto la guida della Caritas nazionale. “Nel 2020 avevo ventun anni” racconta Tony. “Per 64 giorni dal momento dell’esplosione, io e gli altri volontari, soprattutto i team leader non siamo mai tornati a casa. Chi poteva rientrava dalle proprie famiglie alle 4 del mattino, giusto il tempo di una doccia e di un caffè, per poi mettersi nuovamente in servizio. Siamo stati nei centri operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per quanto mi riguarda la situazione è stata ancora più delicata… eravamo in piena pandemia Covid e i miei genitori non godono di buona salute; per cui lasciavo la borsa con i panni sporchi all’entrata di casa, dove mi aspettava mia madre che mi consegnava un’altra borsa con il cambio pulito. Questa è stata la mia vita per più di due mesi”.

Ma l’impegno di Tony non si è “limitato” a questo: nel periodo dell’emergenza, poco più che ventenne, è stato ogni giorno il coordinatore di 1.200 volontari e si è occupato di prestare soccorso ai moltissimi feriti durante le manifestazioni antigovernative, che si sono tenute a Beirut la prima domenica dopo l’esplosione ricordata dai libanesi come il black Saturday, il sabato nero.
Dalle 17 del pomeriggio di quel sabato 8 agosto, centinaia di cittadini si radunarono nel centro della città. Piazza dei Martiri, simbolo delle proteste popolari iniziate nel 2019, tornava ad essere il punto di riferimento dei libanesi per una manifestazione il cui slogan principale era “Il giorno del giudizio”.
I dimostranti chiedevano a gran voce giustizia, chiedevano di identificare tutti i responsabili della tragedia. Una rabbia diretta soprattutto contro una classe politica giudicata dal popolo libanese inetta e corrotta. Una rabbia scandita al grido di “Thawra! Thawra!” che significa “rivoluzione”.
Tony, poco più che ventenne, è stato ogni giorno il coordinatore di 1.200 volontari e si è occupato di prestare soccorso ai moltissimi feriti durante le manifestazioni antigovernative
“Sapevo che quel giorno sarebbe stato terribile, che ci sarebbero stati scontri” prosegue Tony “Per cui ho mandato a casa tutti i volontari, tranne quelli esperti di primo soccorso. Abbiamo allestito un punto sanitario a Piazza dei Martiri. Con me erano 6 infermieri e 4 medici. I manifestanti si erano riuniti vicino al Parlamento, minacciavano di entrare. Ed è stato allora che la polizia ha iniziato a sparare lacrimogeni e proiettili di gomma sulla folla, ad altezza d’uomo. Ho visto e curato molte ferite profonde, tante le teste spaccate dai manganelli. Ai manifestanti in condizioni peggiori dicevo “non possiamo curarvi, dovete andare in ospedale, in una struttura attrezzata”; e spesso mi sentivo rispondere “pensi che se avevamo i soldi per pagarci un ricovero in ospedale saremmo scesi in piazza?”. La situazione del Paese dei Cedri è infatti drammatica: l’80% della popolazione è in povertà, il sistema sanitario è quasi totalmente privatizzato per cui la salute non è più un diritto ma è appannaggio di chi ha la possibilità di pagarsi le cure. il 46% della popolazione è alla fame secondo i dati riportati nell’ultimo rapporto del World Food Program. La lira libanese si è svalutata del 90%. Poco meno di 4 milioni di abitanti, un milione e mezzo di profughi siriani, mezzo milione di profughi palestinesi vivono in un Paese che sta collassando. “Il Libano giorno dopo giorno sta perdendo il suo capitale umano. Migliaia di giovani ogni anno lasciano la propria terra, con la speranza di costruirsi altrove una vita dignitosa. E sono i giovani “migliori”: laureati, con diversi master universitari e dottorati alle spalle, che si sono formati nelle università più prestigiose del Paese”, afferma il volontario Caritas. “Non li biasimo, capisco la loro scelta. La mia, per ora, è di restare. Ma non so fino a quando”.