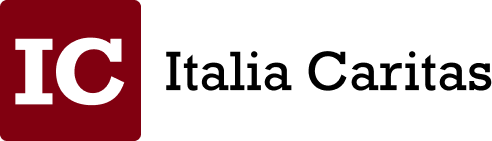Morte e seminagione di Mohibullah

La pace è un affare complicato.
Spesso trova sul proprio cammino volti di amici con mani violente, incespica in illusorie promesse di libertà armata e si rannicchia quando un suo paladino viene massacrato dai propri simili.
Mohibullah è morto, è stato assassinato a fine settembre da una serie di proiettili sparati a bruciapelo per le vie di Cox’s Bazar, per le strade di quella immensa umanità dei Rohingya che, nelle baracche o nei campi profughi del Bangladesh, cerca salvezza da una oppressione storica, quasi atavica, subita in una delle proprie terre di origine, il Myanmar.
Da anni lottava per la pace e i diritti dei Rohingyia,
che nei campi profughi del Bangladesh cercano
riparo dall’oppressione atavica subita in Myanmar
Mohibullah era uno dei leader dell’Arsph, il gruppo per la pace e i diritti umani del popolo Rohingyia, e da anni lottava per i diritti della propria gente, denunciando le violenze dell’esercito birmano, testimoniando l’esodo di centinaia di migliaia di persone e promuovendo dialoghi di pace nei campi, tra le popolazioni ospitate e quelle ospitanti e tra i vari gruppi all’interno della stessa comunità Rohingyia.
Aveva 48, l’ex insegnante, diventato vittima, rifugiato e poi condottiero di pensieri e azioni di pace.
Un nome inutilizzabile
A Cox’s Bazar, Bangladesh sud-orientale, c’è il campo profughi, ovvero la concentrazione di profughi più grande al mondo. Ospita da decenni, ma con un’impennata negli ultimi 4 anni, i rifugiati in fuga dal Myanmar, a causa delle violenze delle truppe governative contro una etnia del paese, appunto i Rohingya. Popolazione che, in patria, non solo è deprivata dei diritti fondamentali, relegata in aree specifiche con divieto di accesso a personale non-militare, punita duramente per il suo organizzarsi per rivendicare i diritti di base, violentata negli individui e socialmente, ma vede negato il diritto all’identità e all’esistenza. L’etnia, infatti, non è riconosciuta in Myanmar. E addirittura il nome “Rohingya” non può essere usato per identificare i suoi componenti.
Nel 2017 le violenze contro il gruppo etnico, ad opera dell’esercito regolare birmano e in seguito ad attentati terroristici contro la polizia locale, hanno portato all’uccisione di un numero non definito di persone, comunque tra i 6.500 e i 10 mila. Ciò ha causato un esodo di massa verso il vicino Bangladesh, e l’afflusso di 600 mila persone nel campo di Cox Bazar. Al conto tra fuggiti e arrivati al campo vanno sottratte le migliaia di persone che sono morte durante il tragitto.
Confinati sull’isola
L’area di Cox’s Bazar è stata teatro, nello scorso marzo, di un terribile incendio, che ha devastato quattro dei numerosi campi profughi che vi si trovano. Dopo di allora, migliaia di profughi sono stati spostati, contro la propria volontà, ad opera del governo del Bangladesh, in un’isola della baia, lontana, deserta e altamente soggetta ai cicloni che flagellano il paese.
I profughi già trasferiti sono più di 14 mila, mentre il progetto prevede lo spostamento di almeno 100 mila persone. Il loro “trasferimento” fa parte di un progetto del governo per alleggerire la tensione demografica nei campi di Cox’s Bazar, ma è stato fortemente osteggiato da molte organizzazioni umanitarie, che chiedevano maggiori garanzie in termini di protezione, soluzioni abitative, sicurezza.
Le innumerevoli promesse da parte del Myanmar di riaccogliere i profughi e del Bangladesh di favorirne un rientro sicuro rimangono intanto lettera morta. Le terribili condizioni di vita cui i profughi sono costretti, nelle vecchie e nuove collocazioni, continuano così ad alimentare disagio, malcontento, tensioni, violenze.
Divisioni interne. E violente
La pace, insomma, è un affare complesso.
La stessa comunità dei profughi Rohingya, infatti, presenta al proprio interno divisioni importanti, soprattutto per l’infiltrarsi di gruppi armati, gli stessi che in patria hanno inasprito lo scontro con il governo centrale, in una spirale in cui non di distinguono le cause e gli effetti.
L’esercito della salvezza del Rakhain (Arsa) è nato per combattere le ingiustizie del potere centrale del Myanmar e lo fa sempre con la violenza, le armi e le bombe. Lo fa, in teoria, per la difesa del proprio popolo, i Rohingya, fino a non sopportare che un leader pacifico e stimato dal quasi milione di profughi in Cox’s Bazar potesse diventare un esempio.
La stessa comunità Rohingya ha al proprio interno
divisioni importanti, per l’infiltrarsi di gruppi armati,
che in patria hanno inasprito lo scontro col governo
Così, dopo le minacce, ecco l’azione. Ad alcuni giorni dal delitto, alcuni militanti dell’Arsa sono stati arrestati e incriminati per l’uccisione di Mohibullah.
In realtà, proprio perché il terreno che la ospita è complesso, da tempo ormai nei campi di Cox’s Bazar la pace si mischia alla sofferenza, alla lotta per la vita, alla ricerca della dignità, al pericolo di una natura che non perdona. E anche alle minacce dell’estremismo di matrice musulmana, che trova consensi nel dolore, nella rabbia e nel bisogno di affiliazione identitaria di alcuni giovani profughi.
Milioni di passi percorsi
Così, ancora oggi non si sa di quante sfumature di violenza sia dipinto l’omicidio di Mohibullah, leader credibile, mite e deciso.

Si sa che la gente ha paura, ora più di prima. Si sa che nella paura risiede l’istinto di sopravvivenza e di attacco. E che la già tortuosa storia di questo popolo esule, da quel 29 settembre, è diventata ancora più incerta e pericolante.
La speranza è che i semi lasciati da Mohibullah, in questi anni, nei milioni di passi da lui percorsi nelle baracche di Cox’s Bazar, possano germogliare, nutriti dal suo sacrificio.
Aggiornato il 22/10/21 alle ore 23:25