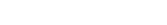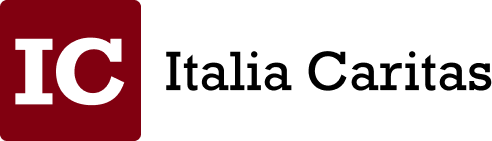COP30 – Negoziati al primo giro di boa

Un percorso negoziale in cerca di direzione
La COP30, presieduta dal Brasile, ha aperto i lavori con sei priorità strategiche: transizione energetica, tutela di foreste e biodiversità, trasformazione dei sistemi agricoli e alimentari, resilienza di città e infrastrutture, sviluppo umano e sociale, e fattori abilitanti come finanziamenti e tecnologia. Alla conferenza hanno partecipato oltre 56.000 delegati provenienti da 193 Paesi; la delegazione brasiliana è la più numerosa, mentre gli Stati Uniti non hanno inviato rappresentanza ufficiale.
l processo negoziale si presenta in una fase particolarmente delicata: i Paesi riconoscono l’urgenza di rafforzare l’azione climatica, ma faticano a trovare un terreno comune per obiettivi ambiziosi e condivisi. Alcuni capitoli avanzano, altri restano in stallo: le questioni chiave saranno affrontate questa settimana dai ministri e dai rappresentanti di alto livello, con finanziamenti adeguati, indicatori misurabili e sistemi di rendicontazione, soprattutto per supportare i Paesi più vulnerabili. Durante la prima settimana di lavori è emerso un certo ritardo nella discussione di alcuni obiettivi, legato alla necessità di maggiori accordi su emissioni e flussi finanziari, con particolare attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici. La presidenza ha sottolineato come sia fondamentale tradurre gli impegni in azioni concrete e rafforzare la cooperazione multilaterale, con strumenti che permettano non solo la definizione di politiche, ma anche la loro effettiva attuazione sul territorio. È evidente che nessun Paese può affrontare da solo sfide di tale portata: sono necessarie risposte multilaterali, in grado di unire competenze, risorse e responsabilità condivise. In questo contesto, la cooperazione internazionale e i processi negoziali multilaterali diventano strumenti fondamentali per costruire soluzioni comuni, durature e inclusive. Un quadro multilaterale è importante per riconoscere che le responsabilità non possono essere identiche per tutti: chi ha maggiormente contribuito al riscaldamento globale ha un dovere proporzionato nel sostenere chi oggi subisce i costi più elevati degli impatti climatici.
La governance multilivello al centro dell’agenda
Durante la COP30, il Brasile ha posto l’accento sul multilateralismo e sulla cooperazione multilivello, integrando governi nazionali, enti locali e società civile attraverso un nuovo piano multilivello. Il Piano di Accelerazione per la Governance Multilivello (PAS) si articola su quattro assi principali: decisioni informate sui rischi climatici, rafforzamento di conoscenze e competenze, mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati e promozione di una governance inclusiva. Entro il 2028, 100 piani climatici nazionali dovranno includere strutture multilivello, salendo a 120 entro il 2030. Le città sono al centro dell’azione climatica, con la Coalizione CHAMP (Brasile e Germania) a guidare la cooperazione tra Nord e Sud del mondo. Nel quarto Incontro Ministeriale su Urbanizzazione e Cambiamenti Climatici, ministri, sindaci e reti internazionali hanno discusso come tradurre le NDC nei territori, rafforzare la governance multilivello e affrontare temi urbani come caldo estremo, abitare e natura in città. L’iniziativa Beat the Heat, sostenuta da 185 città e 72 Paesi, mira a migliorare la resilienza urbana, ridurre la povertà energetica e creare rifugi climatici, traducendo la Global Cooling Pledge della COP28 in azioni concrete di mitigazione e adattamento. Il Brasile ha sottolineato la necessità di una COP inclusiva, integrando i popoli indigeni nei negoziati: durante la manifestazione pacifica avvenuta durante la conferenza, la comunità Munduruku ha dialogato con la presidenza e le ministre Marina Silva e Sônia Guajajara, esprimendo preoccupazioni sugli impatti delle decisioni sulle popolazioni e sui cambiamenti climatici e chiedendo maggiore partecipazione e tutela nei processi decisionali.
Adattamento: la sfida urgente per le comunità vulnerabili
La COP30 ha avviato negoziati concreti sull’adattamento climatico, essenziale per proteggere comunità vulnerabili da siccità, inondazioni, ondate di calore e innalzamento del livello del mare Al centro dei lavori ci sono il Global Goal on Adaptation (GGA) e i Piani Nazionali di Adattamento (NAP), strumenti per pianificare azioni efficaci e misurabili. Si è parlato molto anche dei flussi finanziari, in particolare i paesi in via di sviluppo chiedono un incremento dei flussi da parte dei paesi sviluppati. Le parti hanno avviato la revisione della bozza negoziale dei Piani Nazionali di Adattamento (NAPs), procedendo sezione per sezione. Restano aperte questioni cruciali come la definizione di indicatori condivisi, il monitoraggio e la valutazione delle azioni (MEL), i finanziamenti adeguati e l’inclusione di principi trasversali quali diritti, genere e responsabilità comuni ma differenziate (CBDR-RC). I Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari (AOSIS) chiedono maggiore trasparenza, volontarietà nell’utilizzo degli indicatori e un sostegno più forte da parte dei Paesi più ricchi, sostenendo che le loro capacità tecnologiche e finanziarie limitate condizionano profondamente la possibilità di attuare strategie di adattamento reali. Sul fronte finanziario, è stato concordato un Nuovo Obiettivo Collettivo Quantificato (NCQG) che fissa un impegno di almeno 300 miliardi USD all’anno entro il 2035 per l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo, mobilizzati da una varietà di fonti (pubbliche, private, bilaterali, multilaterali). Tuttavia, solo il 26 % della finanza climatica globale è attualmente destinato all’adattamento, spesso sotto forma di debito, mentre la finanza privata mobilizzata per l’adattamento è molto limitata. I Paesi in via di sviluppo chiedono quindi fondi pubblici prevedibili e concessionali, puntando a un aumento fino a 120 miliardi USD/anno entro il 2030, per garantire che i NAP siano finanziabili e attuabili. Queste misure sono fondamentali per promuovere una giustizia climatica reale, affinché chi è maggiormente colpito abbia risorse adeguate e non paghi lo stesso prezzo dei Paesi più ricchi.
La giusta transizione
La transizione ecologica comporta trasformazioni profonde nei sistemi energetici, produttivi e sociali di ogni paese. La COP30 ha posto grande attenzione alla Giusta Transizione, che mira a trasformare sistemi energetici, produttivi e sociali senza lasciare indietro lavoratrici, lavoratori e comunità più vulnerabili. Il tavolo negoziale principale è la Just Transition Work Programme, che si è occupato di definire una transizione giusta da un’economia fossile a un’economia resiliente e a basse emissioni, in grado di rispettare tutti i diritti umani. Durante il negoziato sul Just Transiction Work Programme si è aperta una netta frattura tra le delegazioni dei Paesi in via di sviluppo e quelle dei Paesi sviluppati, che hanno criticato il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) poiché non rispetta uno dei principi fondamentali dell’Accordo di Parigi, definito dall’articolo 2.2, cioè il principio delle Responsabilità Comuni ma Differenziate e delle Rispettive Capacità (CBDR-RC). Nella pratica, questo principio afferma che tutte le nazioni hanno la responsabilità di affrontare la crisi climatica, perché è un problema globale, ma non tutte hanno la stessa responsabilità storica né le stesse capacità economiche o tecnologiche per farlo, e che quindi gli obblighi non possono essere identici.
Molti Paesi — in particolare quelli in via di sviluppo — temono impatti negativi sul lavoro, sulla sicurezza economica e su settori industriali strategici. I negoziati evidenziano una spaccatura tra i paesi sviluppati e i paesi non sviluppati. Il JTWP, avviato alla COP28, offre un quadro pluriennale, ma attualmente manca un organismo operativo dedicato e risorse sufficienti.
Da qui l’esigenza tra i paesi in via di sviluppo di proporre uno strumento operativo per mettere in pratica i principi della Giusta Transizione. Il G77+China ha chiesto la creazione di un meccanismo istituzionale per coordinare gli sforzi, il trasferimento tecnologico, l’accesso ai finanziamenti e il monitoraggio dei bisogni; mentre molti Paesi sviluppati propongono di rafforzare strumenti già esistenti, per evitare duplicazioni e spreco di risorse. Il Belém Action Mechanism (BAM) si articola su tre pilastri: 1) una cabina di regia per coordinamento, monitoraggio e raccolta dati; 2) un hub di conoscenze per favorire lo scambio di pratiche tra Paesi, esperti e comunità; 3) una componente di supporto concreto per identificare finanziamenti e tecnologie, rimuovere ostacoli e collegare progetti, esperti e finanziatori. Le reti della società civile hanno inoltre sottolineato che oggi solo il 2,8 % della finanza climatica internazionale sostiene iniziative di giusta transizione. Tra le priorità figurano la protezione sociale, la formazione professionale, il rispetto dei diritti dei Popoli Indigeni e delle comunità locali, incluso il consenso libero, previo e informato, e il supporto all’accesso a cibo, acqua ed energia.
L’uscita dai combustibili fossili
La COP30 ha posto l’accento sulla necessità di una transizione energetica equa e graduale, con particolare attenzione alla riduzione dell’uso di carbone, petrolio e gas. Per tradurre gli impegni politici in azioni concrete, sono stati individuati diversi strumenti chiave a supporto della transizione dai combustibili fossili e del raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Tra gli strumenti, assume grande rilevanza la creazione di una roadmap sull’uscita dai combustibili fossili e il rafforzamento dell’impegno globale a limitare l’incremento della temperatura a 1,5 gradi Celsius. Il Brasile, con il sostegno della Cina, mira ad una roadmap per una transizione “ordinata” dalle fonti fossili entro il decennio, dando concretezza agli impegni presi nella COP28 di Dubai, attraverso un approccio più moderato e pragmatico, così da preservare la propria posizione di leadership e mediazione regionale, cercando di mantenere un equilibrio interno ed esterno alla regione, evitando di favorire unilateralmente un paese rispetto agli altri. Insieme al Brasile anche la Colombia si sta distinguendo come attore particolarmente proattivo sul tema dell’uscita dai combustibili fossili, promuovendo iniziative diplomatiche e operative per accelerare la transizione energetica. In particolare, il paese ha annunciato un vertice internazionale per la primavera 2026 dedicato al “phase-out” dei fossili, con l’obiettivo di consolidare una roadmap globale per una transizione equa e giusta. Gli altri Paesi ribadiscono l’urgenza di ridurre gradualmente l’uso di combustibili fossili, pur con approcci diversi:
- Paesi sviluppati (UE, Giappone, Australia, Regno Unito) puntano a roadmap più vincolanti per carbone e petrolio, ma con attenzione a non compromettere la sicurezza energetica interna e la competitività industriale. Alcuni sostengono meccanismi di transizione graduale accompagnati da incentivi per energie rinnovabili.
- Paesi in via di sviluppo e LDC chiedono flessibilità: sottolineano che un phase-out troppo rapido rischierebbe di gravare sui costi, sulla crescita economica e sulle comunità locali; richiedono sostegno finanziario e tecnologico dai Paesi sviluppati.
- Piccoli Stati insulari (AOSIS) e Paesi più vulnerabili enfatizzano l’urgenza climatica e spingono per target più ambiziosi, con accesso diretto a finanziamenti per accelerare la transizione e ridurre la dipendenza dai fossili.
Una COP decisiva per i prossimi decenni
La COP30 di Belém rappresenta così un passaggio cruciale per i prossimi decenni: è l’occasione per intrecciare strategie globali con giustizia sociale e ambientale, dando priorità alle comunità più vulnerabili e costruendo risposte multilaterali fondate su solidarietà, equità e partecipazione. Questa seconda settimana sarà decisiva per trasformare impegni politici in azioni concrete, rafforzare il principio di responsabilità comune promuovendo un patto globale che metta al centro sostenibilità, dignità delle persone e coesione internazionale.
Aggiornato il 19/11/25 alle ore 16:37