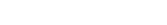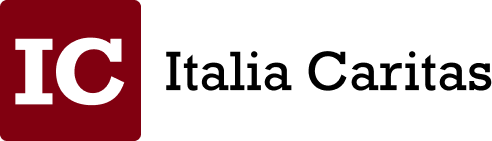La “stranierità” da riscoprire

(Foto: Agenzia Romano Siciliani, in Migranti Press)
La consapevolezza dell’intima connessione tra ciascuno di noi e gli altri va ridestata, in un tempo che è caratterizzato dalla “morte del prossimo”. Ma questa morte porta con sé inevitabilmente anche la nostra condanna a morte!
Nel famoso racconto biblico genesiaco, “l’operazione chirurgica” del Dio creatore, che dal fianco dell’Adam (il tirato dalla terra, sessualmente ancora indistinto) dà origine a «un aiuto che gli sia di fronte» (Gn 2,18b), significava che solo una mancanza, una perdita, apre un essere all’alterità e che non è possibile una relazione autentica se non accetto di essere ferito, mancante, mendicante.
Ma già le Sacre Scritture ci ricordano che, purtroppo, non è sempre così, e Caino ne è la prova. La Genesi ci ricorda anche che Dio pose sulla fronte del fratricida, un segno per preservarlo dalla vendetta del primo venuto. Perché la rottura delle relazioni alimenta il circolo vizioso della violenza e rende impossibile il rapporto stesso con Dio!
“Non è possibile una relazione autentica se non accetto di essere ferito, mancante, mendicante”
Il Cristo, si spingerà ancora più lontano istituendo la relazione, la Cura dell’altro e cioè la prossimità dell’essere umano all’essere umano, alla stessa altezza della prossimità di Dio all’umanità. Non potremmo interpretare diversamente delle affermazioni come «In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». (Mt 25,40).
Oggi siamo chiamati a riscoprirlo senza esitazioni, come credenti e, soprattutto, come cristiani, leggendo tra le righe di una storia che è caratterizzata in modo particolare dalla mobilità umana, spesso e volentieri non frutto di una libera scelta, ma di drammatiche condizioni di vita. Siamo chiamati a istituire un pensiero a partire e non malgrado l’esistenza dello straniero, un pensiero dove la condizione di “stranierità” non rappresenti una condanna ineluttabile o una minaccia da scongiurare, ma piuttosto una parola da accogliere che, una volta accolta, genera una nuova etica e un nuovo pensiero al cui centro non si erge più “l’io” ma “l’altro”, come via d’irruzione dell’Assoluto nella storia.
Bisogna ripensare il migrare, tratto caratterizzante la post-modernità, come a un “luogo teologico”, cioè un ambito che ci permette di percepire aspetti originali ed essenziali del Dio della nostra fede, uscendo da una concezione pauperistica del migrante, che apre solo a una prospettiva assistenzialistica e non alla teologia.
“Bisogna sapersi cogliere come stranieri e pellegrini”
Per secoli, la teologia della migrazione è ruotata attorno a una “stranierità” colta nel suo senso escatologico: che implica, cioè, un distacco progressivo da questo mondo come espressione di una tensione verso un Regno che non è di questo mondo. Ebbene, in una stagione in cui si assiste a dei fenomeni di chiusura, di ripiegamento su sé stessi, dove l’altro è respinto come minaccia o, nella migliore delle ipotesi, è considerato come “semplice oggetto” di sfruttamento economico, o come interlocutore che devo condurre, volente o nolente, alla “mia verità”, la “stranierità” è da riscoprire non nel senso dell’abbandono di questo mondo, ma come invito ad abitare diversamente questo mondo, secondo una logica non dell’appropriazione, ma della gratuità.
Bisogna sapersi cogliere come stranieri e pellegrini perché è su questo sentiero che il Risorto si mette sulle nostre tracce, come l’Accogliente che si fa accogliere per aprirci al senso delle Scritture (cfr Lc 24); un Dio che si rivela in modo inatteso e sorprendente: il “totalmente differente” che si dimostra, tuttavia, non “indifferente” alla nostra umanità.
* Teologo e direttore del DoSt-I, centro culturale domenicano di Istanbul | in Migranti Press 6 2025
Aggiornato il 22/07/25 alle ore 17:00