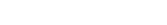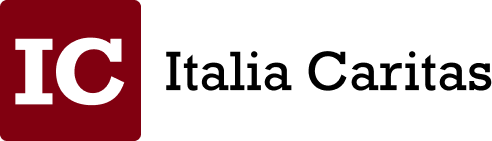E qualcosa rimane

Matteo ha trascorso un periodo di tre settimane, insieme ad altri tre suoi colleghi, da volontario, a Nias in Indonesia, presso uno dei progetti storicamente supportati da Caritas Italiana. Le sue domande e le sue riflessioni.
Perché fare servizio?
Penso che questa sia la domanda che sfiora la mente di chiunque decida di dedicare del tempo al volontariato servendo a una mensa, imbarcandosi in una missione umanitaria – insomma, mettendosi al servizio degli altri. Le risposte, benché diverse, le conosciamo tutti: “Vorrei poter fare la differenza”, “Desidero mettermi a disposizione degli altri”, “Vorrei portare aiuto a chi è meno fortunato di me”.
Erano le stesse risposte che mi ripetevo anch’io nelle precedenti esperienze di servizio, e che risuonavano ancora più forte all’avvicinarsi della nuova partenza. Insieme a tre colleghi dell’università, avevamo scelto di dedicare un mese della nostra estate a un’esperienza diversa, che andasse oltre il semplice rilassarsi dopo un’estenuante sessione di esami. Così, rivolgendoci a Caritas Italiana, abbiamo trovato un’occasione: partire per l’Indonesia, e prestare servizio per tre settimane in un orfanotrofio dell’isola di Nias.
Durante il lunghissimo viaggio di andata – quattro voli estenuanti, per un totale di 35 ore – le risposte alla grande domanda hanno continuato a risuonare sempre più insistenti nella mia testa, più come una rassicurazione necessaria che una prova di sicurezza.
Eppure… se le risposte le sapevamo già tutti, la domanda era davvero quella giusta?
Quali sono i modi in cui fare servizio?
Nelle settimane che ci separavano dalla partenza, avevamo approfondito quanto più possibile il luogo in cui avremmo dovuto operare e la sua cultura. L’isola di Nias si trova a nord ovest della ben più conosciuta Sumatra. Non è molto estesa — cinque volte più piccola della Sicilia, per intenderci, ma presenta una densità abitativa molto alta. Degli oltre 800.000 abitanti, molti sono sparsi in centri minori ed enclavi disseminate per la giungla che ricopre il territorio, in condizioni che erano già estremamente precarie prima che, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005, uno tsunami e un devastante terremoto mettessero in ginocchio l’intera isola. Oggi circa 140.000 persone si trovano a Gunungsitoli, capoluogo della regione e destinazione finale del nostro lungo viaggio.
Alcuni, nel nostro piccolo “gruppo di spedizione”, avevano già svolto qualche esperienza di volontariato in passato: riqualificazione ecologica, servizio in mensa, supporto in contesti di povertà urbana, lezioni di italiano per persone migranti. Durante il nostro soggiorno a Gunungsitoli abbiamo svolto mansioni che richiedevano, a seconda dei casi, competenza linguistica, pazienza, comprensione umana oltre che verbale, inventiva, metodo e grande adattabilità.
Nessuno di noi, però, si era mai ritrovato sul campo in contesti di povertà estrema. Nessuno di noi, quindi, poteva immaginare la varietà di sfaccettature che assume il ruolo del volontario quando è immerso nel contesto di intervento al 100 per cento – un insieme che comprendeva tutte le caratteristiche sopra elencate, e altre che non avremmo neppure sospettato.
La competenza linguistica, in un contesto in cui la comprensione dell’inglese era pari a zero, è stata fin da subito la sfida più grande: l’indonesiano di per sé non è una lingua complessa, ma così come il dialetto locale deriva da radici linguistiche completamente diverse dalle nostre. Abbiamo dunque dovuto procedere per gradi. Siamo partiti da una situazione quasi surreale, fatta di sorrisi imbarazzati, ricorso sfrenato a Google Translate (che spesso non risparmiava incomprensioni tra l’esilarante ed il disperato) e affidamento ai pochi ragazzini dell’orfanotrofio che avevano studiato un minimo di inglese.
Grazie alla lingua, la situazione si era ribaltata: i bambini che incespicavano e avevano bisogno di una mano eravamo diventati noi.
Ma, proprio come bambini, abbiamo imparato presto a camminare: un inciampo e un malinteso alla volta, tra una lezione di indonesiano con il nostro preziosissimo interprete Kevin, la ripetizione costante di parole chiave come makan (cibo), tidur (dormire), air (acqua), terima kasih (grazie) e le risate interminabili dei bambini ad ogni nostra storpiatura linguistica. Così abbiamo sviluppato, in un paio di settimane, un personale “vocabolario di sopravvivenza”.

Un vocabolario che, tuttavia, spesso non bastava. Diversi ragazzini dell’orfanotrofio di Alma Gunungsitoli presentavano serie disabilità fisiche e mentali. E questo ha richiesto uno sforzo ulteriore da parte nostra: da un lato di inventiva, dall’altro di comprensione non verbale, per venire incontro ai modi più disparati e meravigliosi con cui i bambini e le bambine sostituivano perfettamente il linguaggio verbale per comunicarci felicità, affetto, preoccupazione e curiosità.
A mano a mano che ci siamo addentrati in questa esperienza di vita, ci siamo resi conto che non esisteva un metodo unico. E che un metodo, in generale, non poteva esistere senza una buona dose di adattabilità: adattarsi a un’idea di organizzazione molto diversa dalla nostra, agli imprevisti di ogni tipo, al meteo di una terra incredibile come l’Indonesia – dove una giornata di sole può trasformarsi in un monsone di venti minuti, e poi liberare nuovamente il cielo.
Ma, più di ogni altra cosa, ci siamo dovuti adattare alle attività con i bambini. È nei giochi di gruppo, in difficoltose ma divertenti “lezioni” di inglese e matematica che abbiamo compreso la necessità non tanto di uscire dagli schemi, quanto di crearne uno diverso per ogni singola occasione. Nello spazio del gioco riuscivamo a cogliere opportunità e potenzialità nascoste, che dapprima si mostravano prima con timidezza, poi con orgoglio: così il talento nel canto di Tea, la passione per la matematica di Elys, la bravura nel disegno di Karin, la curiosità e l’inclinazione ad imparare l’italiano di Chiko. Ognuno con la propria personalità spesso caotica e variopinta, ognuno con il proprio piccolo scrigno di tesori.
Eppure, anche così, dopo giornate frenetiche immerse nel gioco e nelle attività, mi sono chiesto spesso se stessi facendo tutto al massimo delle mie possibilità. Il che porta direttamente alla prossima domanda.
Quanto può realmente essere utile un volontario in servizio?
“Qual è l’impatto che si può lasciare facendo servizio?”. Ce lo avevano spiegato molto bene durante gli incontri di formazione forniti da Caritas prima della partenza: da volontari, non potevamo avere la pretesa di cambiare il mondo. Messa così, sembra una precisazione sensata e condivisibile – nessuno di noi partiva con la pretesa di capovolgere le dinamiche sociali. Ma è stata importante per prepararci all’estremo opposto: lo sconcerto e la frustrazione dettati dall’impotenza. Durante il nostro servizio abbiamo avuto diverse occasioni per esplorare l’isola di Nias ed entrare in contatto con le comunità autoctone, prendendo parte ad attività con bambini locali e alla distribuzione di aiuti essenziali. E lì abbiamo compreso qualcosa che, all’inizio, ci sarebbe probabilmente parso inconcepibile: i bambini dell’orfanotrofio, nonostante le numerose difficoltà del quotidiano, si trovano in quella che a tutti gli effetti è una situazione di privilegio, grazie all’aiuto portato da Caritas Italiana e al lavoro di Sister Fero, Sister Anas e delle altre suore che gestiscono la struttura.
È nei villaggi dell’entroterra, nel cuore della giungla che abbiamo visto condizioni di povertà che difficilmente avremmo potuto immaginare. Le risate e i sorrisi dei bambini stridevano con le casupole improvvisate (stanzoni logori privi dei servizi più basilari) in cui vivevano ragazzi con gravi disabilità psico-fisiche, il cui unico aiuto poteva arrivare dalle visite sporadiche delle suore e degli operatori locali, dopo lunghi viaggi su strade accidentate.
È in quei frangenti che ci siamo guardati negli occhi, incerti su cosa fosse giusto dire o pensare, mentre la nostra idea di cosa significasse “stare bene” veniva radicalmente ricalibrata, così come la percezione di quello che poteva realmente essere il nostro contributo.
“Cosa facciamo davvero qui? Quanto possiamo davvero essere utili?”
Sono queste le nuove domande che hanno cominciato ad affiorare sempre più spesso, mentre i giorni passavano e – impercettibilmente – la nostra esperienza volgeva al termine. E con essa, la cascata di domande che ci ha accompagnati per mesi.
Cosa rimane dell’esperienza di servizio?

Non ammetterlo sarebbe poco onesto: le tre settimane a Nias ci hanno messi alla prova, sia dal punto di vista fisico che mentale. Abituarci a ritmi diversi, un clima caldo, imprevedibile e umidissimo, una dieta decisamente lontana dai sapori mediterranei e un contesto socio-culturale completamente nuovo erano sfide a cui sapevamo di dover far fronte, ma il cui impatto è stata una continua e travolgente scoperta.
Ed è così che, all’improvviso, ci siamo ritrovati la sera del 17 luglio, per un’ultima (piccantissima) cena di addio. Tra i giochi e le prime lacrime nascoste, i bambini ci hanno sommersi di bigliettini in cui hanno provato a racchiudere amore, gratitudine, e – soprattutto – il bisogno di non essere dimenticati. Paradossalmente, era la questione opposta a farmi riflettere: “La nostra presenza qui è stata un soffio, in cui abbiamo dato ciò che potevamo e ricevuto un oceano. Riusciranno a ricordarci?”.
La maggior parte delle domande che mi sono posto nel corso del nostro viaggio ha ricevuto solo risposte parziali, spesso insoddisfacenti. Eppure, a quest’ultima sono sicuro di poter rispondere. Perché della mattina della partenza sono certo che ricorderemo tutto. Il sole più caldo del solito, gli ultimi abbracci, il sorriso e la gioia mai alterati di Nolo, le lacrime di Dewi, Elys e Berlin, e con loro tutto il resto: l’acume e la vivacità di Igo, la guida per le folli strade di Nias di abang Piter, l’esplosività inesauribile di Zaro, la felicità di vedere Arfan imparare a lanciare un pallone, la dolcezza infinita delle piccole Mikaela e Indah.
In uno dei biglietti, un bambino si è firmato caya jauh – luce lontana.
Dunque, è questo che rimane. Non solo a me, a Vale, a Jaco e a Matte, ma a tutte le anime con cui abbiamo avuto il dono di interagire in questa esperienza di vita: un bagliore che splende di luce propria, distante sì, ma sempre ben visibile. E che, ogni volta che fa capolino dall’altra parte del mondo, ci fa fermare un attimo, ci fa respirare. Ci fa sorridere.
[Foto credit: Valentino Lacapria]
Aggiornato il 16/08/25 alle ore 10:53